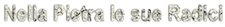La Basì
Una Volta Invece
Spetta/Le Redazione
Appena sessanta anni fa il solo fatto di dovere ricevere un'iniezione, era vissuto come un vero e proprio dramma. Non solo perché si pensava che "forare," una parte del corpo fosse estremamente pericoloso e doloroso, ma soprattutto perché non si capiva bene chi dovesse farlo.
La Basì
(diminutivo di Basilia)
Oggi, spesso ci si lamenta dei tempi biblici che il nostro S.S.N impiega per fare esami clinici, come una semplice ecografia, o una T.A.C. Per la Mutua degli anni cinquanta, il problema non esisteva, non perché più efficiente, ma più semplicemente perché queste macchine eccezionali non erano ancora state inventate. Spesso quando racconto a mio nipote come ci si curava in quegli anni, mi guarda con sufficienza, forse pensando tra se, e se, che io voglia gabbarlo, raccontandogli una favola. Nell’Italia prevalentemente rurale di quei tempi ci si curava ancora con sistemi e credenze vecchie di secoli, in cui la superstizione la faceva da padrona. Esisteva ancora la “magia bianca, ” ossia una serie di riti millenari, che mescolavano la religione e il paganesimo, esercitata in forma assolutamente gratuita, dalle “strolghe, ” donne a metà strada tra le guaritrici, e le sacerdotesse. Quando una persona aveva qualche tipo di malessere, non ben definito, o che non reagiva alle cure, era stata certamente il bersaglio di una “fattura, ” lanciatagli contro, magari in modo involontario, da chi gli voleva male. Il rimedio era quello di portarla a “segnargli la paura.” Il rito abbastanza semplice, avveniva in questo modo: Il paziente era fatto sedere al tavolo della cucina, e l’officiante poneva sotto il suo mento un piatto fondo con un dito d’acqua. Quindi passava ripetutamente sul suo capo in modo circolare uno stoppino acceso dentro un cucchiaio da cucina contenete olio d’oliva, mentre recitava delle formule misteriose, mescolate a preghiere, quindi versava di colpo l’olio dentro il piatto con l’acqua. Se l’olio si frammentava in piccoli “occhi, ” il soggetto, era stato stregato. La medicina tradizionale, traeva i suoi ingredienti dal mondo vegetale, e affidava la guarigione più all’effetto placebo, che all’efficacia dei suoi principi attivi. A un ascesso sotto un dente pesantemente cariato, ben poco potevano fare gli sciacqui con Aceto e Malva, e ben che meno, porre dentro la carie un poco di tabacco. Così per una tosse secca, magari causata da una pleurite, o una polmonite, non credo che potesse portare qualche beneficio, l’impiastro di farina di lino, posto sopra un telo e appoggiato sul torace del malato, a una temperatura vicino a quella di ebollizione. Eppure, in alcuni poderi, dove si faceva la coltivazione del lino, una parte del raccolto era destinata proprio all’uso medicamentoso. Si deve sapere che la pianta di lino può crescere fino a sessanta centimetri, e che proprio come il maiale, di lei si utilizza tutto, dalla fibra, per fare tessuti e cordami, fino ai semi, da cui si ricava olio, e farina. Ma c’è un problema, se si coltiva il lino per l’olio, bisogna raccoglierlo quando la pianta è ancora bassa e ricca di semi, ma la sua fibra sarà di scarsa qualità, al contrario se la si raccoglie per utilizzare al meglio la fibra, dovrà essere alta, ma avrà pochi semi, e quasi privi d’olio. Nonostante ciò una parte del raccolto si sacrificava per uso medico. La zona Apuana ricca di corsi d’acqua, era ottimale per la coltivazione di questa pianta sempre “assetata.” Un tempo la sua coltivazione era predominante, soprattutto per la tradizione che voleva che gran parte del corredo da sposa, fosse fatto di tessuto di lino. La sua coltivazione in Era medievale era così imponente e importante, in alcune zone specifiche di Carrara, che ad alcune di esse è rimasto perfino il nome, come Linara, un agglomerato di case vicino a Gragnana. Anche se è brutto dirlo, fu la seconda guerra mondiale, con le sue spaventose carneficine, che fece fare alla medicina, e alla farmacologia, un prodigioso balzo in avanti. Uno dei farmaci più importanti di quel periodo fu certamente la Penicillina. Questo potente antibiotico, portato in Italia dalle truppe alleate, ebbe non solo il merito da salvare milioni d’italiani da malattie un tempo incurabili, come polmoniti, pleuriti, e in alcuni casi anche la terribile Tbc, al tempo ancora endemica, ma soprattutto ad affrancare la popolazione da sistemi di cura arcaici. Presero sempre più campo i farmaci industriali, al posto di quelli galenici, spesso inefficaci, ma soprattutto cambiò drasticamente il modo di somministrazione di questi nuovi farmaci. Si usarono sempre più le iniezioni intramuscolo. Com’è noto, una pasticca, o qualsiasi altro farmaco preso per via orale, è soggetto a una lunga serie di passaggi, e trasformazioni prima di arrivare all’organo bersaglio. Va da se, che oltre alla tossicità per i vari organi che attraversa, solo una minima parte di farmaco arriva a bersaglio, e poi dopo molto tempo. L’iniezione invece, oltre a poter veicolare molto più medicamento, questo entra quasi subito nel torrente sanguigno, arrivando all’organo bersaglio, prima e in maggior quantità. Tutto bene, ma chi avrebbe dovuto praticare queste misteriose iniezioni? Quasi per miracolo, in tutti i quartieri apparvero delle “infermiere fai da te, ” forse le antiche strolghe, che si offrivano, spesso gratis, per svolgere quest’incombenza. A Monteverde, dove ho passato la mia infanzia, questo compito era svolto dalla Basì. Moglie di un infermiere, veniva a casa dell’ammalato per fare la puntura. Al tempo le siringhe erano di vetro, e gli aghi, non ancora super sottili e affilati come quelli odierni. La siringa completamente smontata dell’ago e dello stantuffo, anche questo di vetro pieno, era posta in un apposito contenitore di alluminio, che in casa del malato era riempito d’acqua e fatto bollire per “almeno dieci minuti.” Poi la siringa era estratta, e lasciata raffreddare, mentre si preparava la fiala del farmaco. Questa era di due tipi, la classica fiala di vetro completamente chiusa, o la boccetta con il tappo di gomma sigillato da una fascetta in alluminio. Per quella in vetro, la Basì usava una minuscola limetta per incidere il collo della fialetta, che poi spezzava con le mani, per aspirare il liquido, mentre per l’altra infilava l’ago nella gomma e aspirava il tutto. Quindi si provvedeva a “levare l’aria, ” agendo sullo stantuffo della siringa fin quando dall’ago, non usciva un po’ di liquido, poi, previa una strofinata sul gluteo del paziente con un batuffolo di cotone imbevuto d’alcool, si procedeva all’iniezione. Questa donna non solo veniva a fare le iniezioni, ma a casa sua, curava le varie sbucciature da caduta di noi bambini, in modo assolutamente gratuito, dimostrando uno spirito altruistico raro. Purtroppo, un proverbio dice che ogni medaglia ha il suo rovescio. Uno studio fatto intorno ai primi anni novanta ha rivelato, che a causa di queste iniezioni praticate in Italia con aghi e siringhe sommariamente, e non perfettamente sterilizzate, più di un milione di persone hanno contratto l’Epatite C, e alcuni, anche la B, senza contare i danni causati da ascessi, fascite necrotizzante, e anche, purtroppo qualche decesso. Nonostante tutto però, da quel periodo quasi pionieristico della Medicina e della Farmacologia, nacquero negli anni a venire, dei veri colossi in campo farmaceutico, e ospedaliero, che oltre a salvare molte vite, portarono l’Italia a essere uno dei leader mondiali nell’assistenza sanitaria.
Mario Volpi 18.9.21
Racconti di questa rubrica